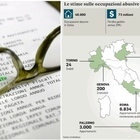Ogni diarchia è segno di decadimento
(Guido Bodrato, politico italiano)
Dirimpetto alle laboriose manovre che da due mesi si protraggono tra Quirinale e Parlamento, alla ricerca di un accordo di governo, più volte si è affacciata l’ipotesi di una diarchia. Ma che cos’è, esattamente? In cosa consiste una diarchia? Dov’è che la Costituzione lascia margini per una simile prospettiva?
Anche in questo caso il politichese in un gioco di allusioni disegna una Fatamorgana, come un miraggio che si scorge in una stretta fascia al di sopra dell’orizzonte. Nella Costituzione non si fa menzione della parola, ma nel vocabolario sì. Provare per credere. Treccani, tornando all’etimologia dal greco antico (di, che sta per due, e arco, per comandare) spiega che la diarchia altro non è che una forma di governo in cui il potere sovrano è esercitato, con pari autorità, da due persone o da due organi. Oggi il termine è riferito a comunità politiche in cui le responsabilità del potere sono condivise da due cariche concorrenti (capo dello stato e capo del governo) o da due organi di diverso genere.

Nella storia esempi di diarchia non sono infrequenti. A Sparta il potere fu per anni esercitato da una coppia di re, delle famiglie degli Agiadi e degli Europontidi. Così come nella Roma repubblicana i consoli erano i due magistrati supremi che esercitavano in maniera collegiale i massimi poteri di guida del popolo e dell’esercito. Una consuetudine che si fa risalire al quinto secolo avanti Cristo e viene attribuita alla determinazione degli optimates a non affidare il potere nelle mani di un uomo solo: determinazione maturata intorno al 509, anno della cacciata dei Tarquini da Roma che segna la fine dell’influenza osca/etrusca. In realtà la consuetudine era già radicata: un primo tentativo di ricorrere alla diarchia era quello che la leggenda attribuiva al regno di Romolo insieme a Tito Tazio, dopo la guerra dei Sabini, esperimento brevissimo perché Tito fu subito ucciso.
Magistrati come i consoli erano meno rari di quanto si pensi nell’antichità. Tant’è che Tucicide, nella guerra del Peloponneso, riferisce dei Caoni, come di un «popolo non sottoposto a potestà regia, su cui governavano, con carica annuale, Fozio e Nicaone e, membri della famiglia dominante».

Anche la Roma imperiale provò più volte la strada della diarchia. Non tanto al termine, quando la divisione tra Impero d’Oriente e Occidente in realtà non consentiva un esercizio condiviso del potere, quanto al principio, ovvero quando Augusto aveva preparato la successione prima designando la diarchia con Gaio Cesare e Lucio Cesare e poi (alla loro prematura morte) aveva ripiegato su Agrippa Postumo e Tiberio, e soltanto dopo che Agrippa fu diseredato ed esiliato Tiberio divenne l’unico imperatore.
Al di là del caso di repubbliche presidenziali nelle quali il potere esecutivo è stato equamente diviso tra presidente e primo ministro come nella Quinta repubblica francese, e dopo il ventennio italiano (dal 1922 al ‘43) quando il Paese vide convivere il re Vittorio Emanuele III e il dittatore Benito Mussolini, attualmente esistono due diarchie sancite dalle rispettive costituzioni: Andorra, dove regnano il presidente della Repubblica francese e il vescovo di Urgell in Spagna, e San Marino, con i suoi Capitani reggenti.
In Italia, in epoca recente, il primo a parlare di diarchia - ma come categoria sociale e non come forma di governo politica - è stato don Luigi Sturzo, per il quale la società umana è caratterizzata dalla diarchia di poteri rappresentata dalla Chiesa, che ricerca il fine spirituale, e dallo Stato, il quale tende al bene comune.

Ma certamente l’utilizzo del termine nel linguaggio politichese è stato particolarmente diffuso nel corso degli anni Ottanta, per indicare l’indiscussa supremazia che nel potere politico esercitarono Dc e Psi attraverso i due storici leader Ciriaco De Mita e Bettino Craxi. Fu Achille Occhetto a sdoganare la parola diarchia, nell’88, o meglio fu Repubblica ad attribuire al segretario Pci l’uso di quella parola in un titolo tra le virgolette («Il pentapartito è una diarchia»). Invero, a leggere il pezzo del celebre notista politico Giorgio Rossi, ci si rende conto che le cose andarono diversamente. Il virgolettato preciso dell’attacco di Occhetto era questo: «Se si va avanti così si rischia di logorare la democrazia sulla quale già si poggia la cappa opprimente di un nuovo doroteismo, di un patto consociativo e di potere fra Dc e Psi». Poi era il notista a proporre l’esegesi: «Parlando di patto consociativo, Occhetto si riferisce, non al puro e semplice accordo di governo fra Dc e Psi, ma a quel consolato, a quella Diarchia di cui si comincia a parlare con evidente malessere nelle segreterie dei partiti».
Tensioni che Occhetto condivideva a distanza con gli altri protagonisti del pentapartito: Renato Altissimo (Pli), Giorgio La Malfa (Pri) e Antonio Cariglia (Psdi). Siamo a dicembre ‘88, cioè poco meno di un anno prima che ufficialmente la diarchia De Mita-Craxi - piena di «improvvisi e reiterati assalti, l’un contro l’altro, dei due segretari» scrive sempre Rossi - abbia fine con la duplice caduta del leader irpino, a febbraio ‘89 da segretario della Dc (subentra Arnaldo Forlani) poi a luglio da presidente del Consiglio (fa strada a Giulio Andreotti).
Ma l’inizio della diarchia va fatto risalire ai primi anni Ottanta. A maggio ‘82 De Mita viene eletto segretario della Balena Bianca (poi un’altra volta cercheremo di capire perché diavolo fu chiamata così) e nell’agosto ‘83 nasce il governo Craxi, considerato da tutti figlio del cosiddetto patto fantasma o dell’alternanza, perché secondo indiscrezioni avrebbe contemplato una staffetta fra i due leader a metà legislatura. La Dc viaggia ai minimi storici: a giugno ‘83 perde il 5,4% alla Camera e addirittura il 6,9% al Senato. L’anno successivo subisce il clamoroso e storico sorpasso dal Pci alle Europee. Ma l’accordo col Psi le dà garanzia ancora di un largo e diffuso potere nella macchina politica e amministrativa del Paese.
Poi arriva l’86 e Craxi, che in pubblico non aveva mai ammesso l'esistenza di un accordo ed era sempre rimasto nel vago, nel corso di una storica intervista in diretta Rai con Giovanni Minoli nega l’ipotesi di un avvicendamento. E pare che all’uscita dagli studi televisivi abbia sbottato: «Così abbiamo liquidato la staffetta». È l’inizio della fine: De Mita fa cadere il governo nella primavera dell’87. Si va ad elezioni anticipate e, dopo un brevissimo incarico a Giovanni Goria, è il leader irpino a conquistare Palazzo Chigi. Non senza tensioni, perché Craxi continuerà la guerra spalleggiato dai due avversari interni di De Mita, Giulio Andreotti e Arnaldo Forlani: nel segno del Caf.
Un bel po’ di anni dopo, nel 2000, De Mita svelò al Corriere della Sera i retroscena del patto della staffetta: «Ci incontrammo in un convento di suore sull’Appia Antica. Proposi a Craxi di guidare il governo perché era l’unico compromesso possibile. Lui fu stupito dell’offerta. E allora rilanciò: metà del tempo a me, metà a te. Risposi facendo notare che non si trattava di una questione personale, ma della Dc. Il cambio della guardia avrebbe dovuto sottolineare l'importanza della coalizione. Poi le cose andarono diversamente…». Dopo quell’incontro, aggiungeva De Mita, i rapporti con Craxi «migliorarono un po’ alla volta e, paradossalmente, furono più intensi quando cominciammo a contare di meno. Io insistevo sull’importanza delle riforme istituzionali, lui subordinava tutto alla guida del governo. Fino al ‘92».
corrado.castiglione@ilmattino.it